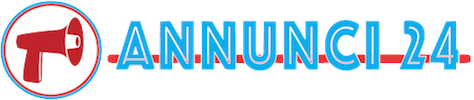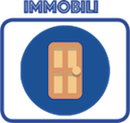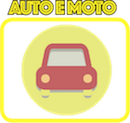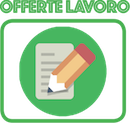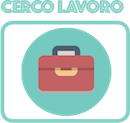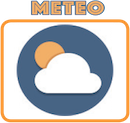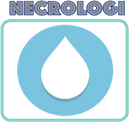L’appassionato monaco riformatore Bernardo di Chiaravalle amava ripetere: “Troverai più nei boschi che nei libri. Gli alberi e le rocce t’insegneranno cose che nessun maestro ti dirà”. E non lesinava di prendere in mano la zappa per pianificare la campagna nei pressi del monastero della “valle chiara” sede dell’ordine cistercense cui apparteneva.
Agricoltura e silvicoltura, due arti spesso in contrasto tra loro perché lo sviluppo incontrollato di quest’ultima fa venir meno le terre da dedicare alla prima.
Qual è lo stato dei boschi italiani? E quelli dell’Ossola? L’occasione per parlarne viene data dalla fotografia scattata dal primo rapporto nazionale dello stato delle foreste e del settore forestale (Raf Italia) presentato a Roma, presso il ministero delle politiche agricole, il ventuno marzo scorso in occasione della giornata mondiale delle foreste.
Ebbene, le selve italiane aumentano, a volte addirittura a dismisura, con un incremento del 5% rispetto all’analoga descrizione fatta nel 2005. I boschi arrivano a coprire il 36% della superficie nazionale con circa undici milioni di ettari completamente boscosi.
Più di un terzo del territorio nazionale è dunque coperto da foreste e queste continuano ad avanzare.
La cosa che a prima vista potrebbe sembrare positiva per la qualità dell’aria e dell’ambiente, non sempre lo è. Il bosco, infatti, ha occupato il posto di pascoli e aree coltivate e la realtà ossolana ne è un chiaro esempio.
Altri aspetti critici evidenziati dal reportage sono l’importazione del legname che è pari a quasi quattro milioni di metri cubi per il grezzo e a circa quindici per il semilavorato e il preoccupante fenomeno degli incendi boschivi che devastano decine di migliaia di ettari ogni anno.
Anche i boschi ossolani avanzano inesorabilmente e conquistano aree un tempo destinate a vigneti e coltivi. Questo ci fa affermare che l’avanzata delle selve non può essere considerata alla stregua di una buona notizia, soprattutto perché essa è il frutto dell’abbandono del territorio e non di politiche mirate a sostegno della silvicoltura.
Non di rado in Ossola si scorgono i prati degli alpeggi ormai abbandonati, soprattutto quelli d’altura, ormai invasi dal bosco ceduo che s’impossessa dell’habitat su cui un tempo pascolavano le brune alpine.
Non parliamo poi dei terrazzamenti ove un tempo, i vigneti la facevano da padrone e oggi, ahimè versano in condizione di grave degrado nonostante qualche timido tentativo d’invertire la rotta.
E pensare che gli antichi agricoltori di montagna ne sfruttavano ogni singolo appezzamento finanche sulle “locce” più ardite.
Quando è iniziato, l’abbandono delle terre alte è ormai risaputo. Il boom economico del secondo dopoguerra con le promesse del benessere industriale e lo sfruttamento dell’acqua per la produzione di energia elettrica hanno indotto sempre più alpigiani a trascurare il loro lavoro alpestre per approdare nelle industrie del fondovalle.
L’abbandono delle terre coltivate o adibite a pascolo ha così favorito l’avanzare delle foreste che ormai ricoprono quasi il 50% del nostro territorio. E pensare che alla fine del XIX secolo l’Ossola era pressoché disboscata e il legname una delle principali fonti di guadagno per la nostra economia!
Oltre alla crescita incontrollata delle foreste, a preoccupare è soprattutto la densità arborea delle stesse. Gli alberi cioè, crescono uno vicino all’altro creando sovente un sottobosco impenetrabile e quindi difficile da gestire.
Quegli alberi che per secoli avevano rappresentato una materia prima fondamentale per lo sviluppo dell’Ossola e l’unica fonte di energia sicura, sono oggi diventati un problema.
Un tempo difficilmente si trovava un ramoscello secco nel bosco e le foglie degli alberi erano tutte utilizzate per lo strame delle stalle o per i giacigli delle case. Oggi invece si deve riscontrare come il degrado e la cattiva gestione abbia raggiunto livelli pericolosi per l’ecosistema del bosco stesso.
Un bosco impenetrabile con il legname sradicato dal vento, dalla neve o da altre cause e abbandonato nel sottobosco, diviene quasi indifendibile in caso d’incendio. Anche le bufere che in questi ultimi periodi hanno flagellato gli alberi facendoli cadere con un effetto domino causa la loro vicinanza è colpa dell’uomo e non della natura.
Una gestione intelligente del patrimonio boschivo, se non eliminare, avrebbe almeno limitato lo sterminio degli alberi.
Spontaneo chiedersi: ma il lavoro del “boscaiolo” è stato proprio abbandonato a queste latitudini? Se si osservassero i dati che arrivano dal ministero pare proprio di sì.
Anche in Ossola, come del resto un po’ in tutta la penisola, ogni anno rinnoviamo, tagliandola il 30% della superficie del bosco. In pratica per ogni cento alberi che nascono, ne tagliamo trenta raggiunti a maturazione.
In Europa, si preleva in media il 60% delle superfici boscose e in alcuni paesi come l’Austria e la Norvegia, si supera addirittura il 90%. Non riusciamo quindi a valorizzare il nostro patrimonio forestale, anzi, paradossalmente importiamo legname da Francia, Austria, Slovenia, Croazia e Svizzera per garantire materia prima alla nostra industria del legno che è tra le prime in Europa per fatturato conseguente a lavorazioni pregiate.
Un ultimo dato su cui riflettere è quello che vede, nonostante i boschi crescano incontrollatamente, l’erosione del suolo a causa dell’avanzata del cemento. In Italia siamo a livelli record per il consumo di suolo: oltre il 7% l’anno.
Siamo dunque stretti in una morsa dalla quale è urgente trovare una via d’uscita. Perché tra cemento da un lato e bosco selvaggio dall’altro, a perderci sono le aree privilegiate dedite all’agricoltura e alla pastorizia. E il venir meno dei nostri prodotti gastronomici migliori.
Pier Franco Midali - 29 marzo 2019