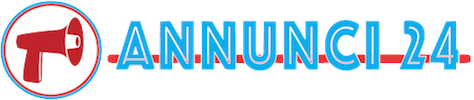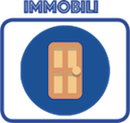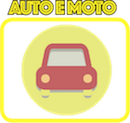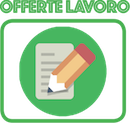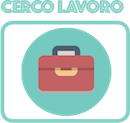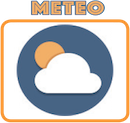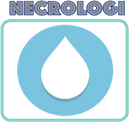Vi è stato un interessantissimo convegno di Architetti ed Ingegneri venerdì
17 marzo che, in qualità di giornalista, ha visto anche la mia partecipazione. Il tutto si è svolto nella cornice neoclassica della Cappella Mellerio, dove sono stati esposti anche dei pannelli illustranti i migliori, più moderni e più recenti progetti di architettura ecosostenibile. Da grande appassionato e studioso di argomenti architettonici sono molto contento che l'Arch. Paolo Volorio si sia soffermato ad illustrare due figure chiave nel panorama Italiano i cui interessi economici e progettistici si svolsero più che altro nello scenario Ossolano: il Senatore Ettore Conti e l'Architetto Piero Portaluppi.
Ettore Conti fu una figura molto nota di imprenditore e finanziere nella Milano di inizio novecento. Figlio di un tabaccaio di Corso Venezia, si laurea molto presto in ingegneria civile e insegna scienza delle costruzioni fino al 1901, anno in cui decide di fondare la società anonima per imprese elettriche Conti che avrà vita autonoma fino al 1926, quando verrà assorbita dalla Edison. Ed è proprio grazie all'intuito del giovane Ingegnere che, come ricorderà lui stesso nel suo libro autobiografico “Taccuino di un borghese”, l'Ossola vivrà il suo grande boom idroelettrico; nel libro difatti Ettore Conti racconta dei suoi primi viaggi in val d'Ossola accompagnato dalla sua devota moglie Giannina Casati, effettuati apposta per "sondare" l'ambiente, effettuando sopralluoghi, rilevazioni meteorologiche e tutto quello che all'epoca poteva servire a costruire opere di tale portata. Ma per realizzare le sue grandiose centrali Conti ha bisogno in un certo senso di un artista che dia un tocco di monumentalità alle sue idee. E proprio nel 1912 avviene l'incontro con Piero Portaluppi, per la realizzazione della grande centrale idroelettrica di Verampio. Ma chi è professionalmente Portaluppi? Di lui si può parlare incominciando col dire che è figlio d'arte, in quanto il padre Oreste era un architetto di una discreta fama nella Milano della seconda metà dell'ottocento, dove Piero nacque il 19 Marzo del 1888. Dal 1905, anno in cui il giovane Portaluppi inizia a frequentare i corsi di architettura al politecnico, retti per oltre quarant'anni da Camillo Boito e successivamente da Gaetano Moretti. I corsi si articolavano in lezioni teoriche e pratiche per un totale di 16-22 ore settimanali, durante i quali agli allievi venivano impartiti i fondamentali concetti di storia dell'arte, i principi dell'architettura greco-romana, e poi si dava il via a dei propri progetti con ovvi riferimenti agli stili studiati; tutto ciò per il primo anno mentre nel secondo si analizzavano gli stili dell'architettura rinascimentale e barocca. Al terzo anno si analizzava invece l'architettura dell'alto e del tardo medioevo. Questa sintesi tra storia e progetti era ben viva negli anni in cui Piero Portaluppi era studente al politecnico, ed è bene ricordare che fin dal 1903 era attivo un corso di storia dell'arte tenuto da Giulio Carotti, in cui gli allievi venivano portati a visitare molti monumenti italiani che potessero essere utili a stimolare la loro fantasia progettuale.
Il giovane Portaluppi si diplomerà nel 1910 con il curioso progetto denominato "albergo in montagna" nel cui, pur con un impostazione di stile che strizza parecchio l'occhio all'opera di Gino e Adolfo Coppedè, si individuano già elementi che entreranno a far parte della futura centrale di Verampio: ne emerge infatti un architettura di impianto fortemente materico ma dalle linee semplici, animata da un pittoresco che gioca sapientemente sulla diversità dei fronti, con un rivestimento alterno di parti lisce e parti corrugate da sassi irregolari, sulle falde spioventi dei tetti, sui larghi aggetti delle gronde. Il voto dell'esame finale fu 10 e Portaluppi divenne Architetto con un punteggio molto alto di 98,33 su 100, primo in graduatoria fra gli architetti di tutto il politecnico.
Come abbiamo già detto prima, nel 1912 iniziano i lavori per la centrale di Verampio che dureranno fino al 1917. L'Architetto progetterà poi un ampliamento nel 1930. Tale impianto presenta, nelle sue caratteristiche principali la centrale vera e propria, quattro piccoli edifici per i trasformatori oltre alla villa per il direttore e una casa per i capiturno. La centrale è articolata nei due volumi della sala turbine e della sala di trasformazione. Al tutto si accede da una terrazza rialzata, raggiunta da un ponte carrozzabile che introduce in un giardino, a livello inferiore, disegnato attorno a una fontana. Tutto il complesso è fantasiosamente neo-medievale, con torri, ogive, bifore e rimanda al tipo del castello, circondato da un borgo. L'Architetto agisce con molta sensibilità sul paesaggio: riesce a mascherare l'arrivo della condotta sotto il piano d'ingresso; completano il villaggio elettrico la villa del direttore e la casa dei capiturno, la prima declinata con toni cautamente modernisti e borghesi mentre la seconda più modesta e vicina all'architettura alpina, con ampie balconate in legno sul modello delle case Walser. Seguirà nel 1916 la centrale di Crego, sempre in valle Antigorio e i cui lavori, a causa purtroppo della guerra, dureranno fino al 1926. La centrale di Valdo (valle Formazza) viene invece realizzata tra il 1920 e il 1924. Nel frattempo Piero Portaluppi si dedica anche ad altri progetti che esulano dall'idroelettrico, il cui più famoso è certamente la ben nota casa degli Atellani, sita in corso Magenta 65 e storica dimora del suo mecenate Ettore Conti. Nel suo “Taccuino di un borghese” Conti parla di sè come di un tecnico avveduto, dai rigorosi principi amministrativi e dalla mentalità sintetica (sono queste evidentemente le doti con cui si definisce un "borghese") ma che aspira anche, forse dalla reminescenza dei suoi primi studi classici, al vivere eletto e a rievocare di tanto in tanto il senso dell'humanitas. Non c'è nulla di meglio quindi per il Conti che fare restaurare da Portaluppi l'antico immobile: qui l'Architetto si sbizzarrisce nella sua originale idea di architettura, recuperando elementi quattrocenteschi e fondendoli con segni zodiacali, meridiane, laterizi tipicamente novecenteschi realizzando quella che a tutt'oggi è considerata la sua opera migliore. Per quanto riguarda il settore idroelettrico, Portaluppi progetta tra il 1923 e il 1925 quello che in tale ambito è forse il suo capolavoro: la centrale di Crevoladossola. In tale edificio il progettista sembra ispirarsi nella facciata come ad una ziggurat babilonese, sopratutto nella curiosissima torretta a pagoda; però vista da fuori la centrale potrebbe essere scambiata anche per un moderno politecnico. Ma in alcune componenti Portaluppi ci conduce direttamente nel regno delle fiabe, come nella casetta a misura di nani della fucina con due altissimi comignoli terminanti in un quadrato con sopra una palla.
L'attività di Architetto di Piero Portaluppi continuerà fino all'anno della morte, avvenuta nel 1967, con il suo ultimo grande progetto: la villa Ciccarelli di Besate.
Alessandro Velli – 25 marzo 2017