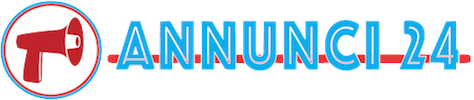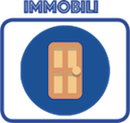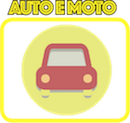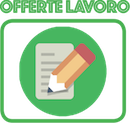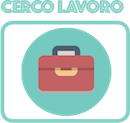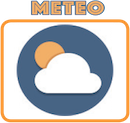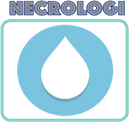DOMODOSSOLA- 30-08-2019- Due mostre dominano l’estate Domese:
quella commemorativa, a cinquantuno anni dalla morte, su Carlo Fornara e le sue radici divisioniste organizzata nella casa mostre privata di Palazzo De Rodis, nella centralissima piazza mercato e quella di risonanza più nazionale sul futurismo, allestita nella pinacoteca di palazzo San Francesco. Due rassegne all’interno del borgo della cultura molto diverse fra loro ma che a mio giudizio hanno qualcosa che le lega. E vedremo come. Incominciamo col parlare di Fornara, della sua formazione e della sua lunghissima carriera di pittore (ben 85 anni, dal 1888 fino al 1964) che ne fanno, senza azzardare troppo, il più prolifico pittore Ossolano e il più famoso pittore Vigezzino. Nasce a Prestinone nel 1871, figlio di un provetto calderaio e di una contadina. Il casato dei Fornara è antico e culla dei suoi avi è Vocogno, dove la famiglia possiede alcune case e terreni oltre alla bella casetta materna situata per l’appunto a Prestinone, dove il piccolo vede la luce. Fin dalla prima infanzia il suo più grande godimento è il disegno e un giorno, durante una messa, disegna un anziano raccolto in preghiera, suscitando l’ammirazione degli astanti. Questo fatto convince i suoi genitori, dapprima un pochettino titubanti sulla sua vocazione artistica, ad iscriverlo nell’anno 1883/1884, quando il fanciullo ha dodici anni, alla Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini sotto la guida del pittore Enrico Cavalli, figura rispettata in Val Vigezzo e “figlio d’arte” ( il padre è Carlo Giuseppe Cavalli, buon pittore anch’esso ma di cui si conoscono pochissime opere, fra cui un notevole ritratto del benefattore Ossolano Gian Giacomo Galletti , recentemente ritrovato nei musei civici di Domodossola e restaurato mirabilmente grazie al contributo di un anonimo benefattore). Nell’anno successivo, troviamo iscritti assieme al promettente giovinetto il coetaneo Giovanni Battista Ciolina e i fratelli Rastellini. Fornara frequentò la scuola fino alll’anno accademico 1890/91, vale a dire per otto anni consecutivi e già nell’autoritratto a sfumino, opera del 1888 conservata presso la scuola si nota la perfetta impostazione di ritrattista datagli dal Cavalli anche se, negli anni seguenti, cercherà un suo stlie più personale nel ritratto. Il Fornara paesaggista dei primi anni di pittura è fortemente influenzato dal Fontanesi, che ha modo di scoprire a Torino e che cerca di imitare in tutti i modi con colori e pennellate assai vivaci. Si reca a Milano nel 1891 e nelle sale della triennale vede per la prima volta dal vivo le due madri di Segantini e maternità di Previati, due capisaldi del nascente movimento divisionista. E’ opportuno precisare che il divisionismo non è altri che una corrente artistica sorta alla fine dell’Ottocento e prolungatasi fino agli inizi della prima guerra Mondiale (1914-15) debitrice sia dell’impressionismo e post-impressionismo che del “Pointillisme” Francese di Georges Seurat e Paul Signac, che possiamo tranquillamente considerare già divisionisti. Va anche specificato che le tecniche di pittura divisioniste non sono tutte uguali e sarebbe un grossolano errore accomunare il divisionismo “a filamenti” di Giovanni Segantini con quello totalmente diverso di un Pellizza Da Volpedo del celebre il quarto stato (Milano, galleria nazionale d’arte moderna) o di speranze deluse (Roma, coll. Privata). Sostanzialmente il divisionismo è un gioco ottico di colori : quando si vede un dipinto realizzato con tale tecnica da una certa distanza esso può sembrare un quadro dipinto normalmente, con colori realizzati da semplici pennellate uniformi. Ma se analizzato da vicino, l’occhio attento del critico o dell’appassionato d’arte che sia noterà subito che il colore uniforme in realtà è stato ottenuto da tante piccole sfumature, siano essi puntini o trattini mischiati in maniera omogenea ottenendo effetti di luce molto particolari, con calibrati rapporti fra colori primari e complementari.La fama a Fornara giungerà, dopo due viaggi in Francia a Lione e a Parigi a scoprire i maestri francesi di cui Enrico Cavalli gli ha tanto parlato, grazie ad un piccolo “scandalo” : il rifiuto alla triennale milanese di un suo grande quadro, intitolato”en plein air”( a tutt’oggi non rintracciato) per troppi “barbarismi cromatici”. A questo punto, i pittori divisionisti accolgono il giovane Carlo Fornara nel loro gruppo e del suo talento se ne accorge subito il loro mecenate, Alberto Grubicy che espone il quadro nella sua galleria di Corso Vittorio Emanuele a Milano. I barbarismi cromatici contestati dalla critica del tempo altri non erano che una interpretazione personale della tecnica divisionista. E qui siamo nel 1897 : alla scuderia di Grubicy Fornara ha modo di conoscere personalmente il leader supremo del movimento, Giovanni Segantini, che andrà a visitare in Engadina nel 1898 e con cui avrà modo di collaborare al cosiddetto panorama Engadinese. La pittura di Segantini influenzerà per breve tempo il giovane artista, che dipinge proprio nel 1898 il famoso pascolo d’Ottobre che verrà addirittura sfregiato in una mostra da un fanatico avversario del divisionismo. Fornara lo salverà dividendolo in due quadri, oggi appartenenti a due diverse collezioni e sulla tela ricavata dalla parte sinistra del dipinto, rimasta senza firma, il furbo Grubicy applicherà la firma apocrifa di Segantini, cogliendo l’opportunità di un facile guadagno e solo molti anni più tardi il vero autore, rintracciato il dipinto, potrà apporre la firma esatta. Giovanni Segantini morirà in alta montagna nel 1899: da quel momento spetta a Carlo Fornara, paesaggista come il defunto maestro, cogliere la sua eredità nella galleria Grubicy. Ma lo stile del pittore Vigezzino è ciò che di più lontano ci possa essere dalla visione allegorica e panteistica della natura Segantiniana. Solo in un primo tempo egli sembra imitare il defunto caposcuola, con quadri come “da una leggenda alpina”, “alba” e “l’aquilone”, opera questa che abbiamo il piacere di avere nella rassegna a casa De Rodis. E’ un quadro questo dai forti connotati simbolici, dai colori innaturali ma vivaci e dipinto anche con un pochino di polvere d’oro, tecnica questa appresa evidentemente da Segantini. Ma ben presto Fornara si stacca dalla corrente simbolica allora dominante, per elaborare un suo stile paesaggistico di pura osservazione dei soggetti rappresentati nelle tele : si pensi ad opere come l’ombra si stende (1908), Fontanalba, mattinata sulle alpi, giorno di pioggia, Cimalmotto, tutte quante dello stesso periodo quando il pittore trascorrerà l’Estate nell’alpeggio Vigezzino “in sui” e sconfinando anche nell’adiacente Valle Maggia, situata in territorio Svizzero e trovando colà una sua piccola Engadina. Fornara continuerà ad esporre fino al 1920; da quel momento in poi farà sua la decisione di non partecipare più a nessuna rassegna pubblica ma sempre continuando a dipingere, sostenuto economicamente da non tantissimi ma fidati collezionisti : il mercante di vini Pozzi di Novara, l’industriale delle cravatte Carlo Tridenti Pozzi di Milano, i fratelli Arturo e Otto Zust (industriali di Zurigo con villa a Intra) la famiglia Bonomi e Carlo Masera di Vigevano, il banchiere Milanese Amedeo Catapano. Nel catalogo della mostra a casa De Rodis è evidenziato come il pittore divisionista con cui Carlo Fornara legò forse di più, almeno epistolariamente è Giuseppe Pellizza da Volpedo, di pochi anni più vecchio e il loro carteggio è stato riportato in una sezione del libro a cura di Anne-Paule Quinsac. Come uomo e come artista Fornara fu certamente molto singolare : come ricorda Guido Cesura in un suo saggio poteva apparire scontroso e sbrigativo con chi considerava dei semplici scocciatori mentre tanto poteva essere prodigo di ospitalità e cortesia con chi reputava dei veri amici. In effetti, a giudicare dalle collezioni personali di chi lo ha frequentato in vita, il pittore sapeva pesare molto bene in fatto di gusti e competenze artistiche chi aveva davanti e di sicuro, se fosse un pittore di oggi non gli andrebbe per niente giù l’iniziativa di vedere un suo quadro campeggiare sull’etichetta di una bottiglia di vino rosso, peraltro dedicata al quadro stesso. Nel 1932 sposa segretamente in San Babila a Milano, dopo una breve convivenza, la giovane Amelia Biscaldi che, nata nel 1908 ha trentasette anni in meno di lui, ormai ultrasessantenne. Nonostante la differenza di età sono anni lieti per la coppia e di feconda produzione artistica per Fornara. Ma il tutto viene interrotto nel 1940, quando una malattia gli porta via l’amata moglie. Il pittore subisce un tragico lutto sia nella vita che nell’arte, dato che per circa due anni non tocca più un pennello, chiudendosi in una profonda depressione. Ma un nuovo incontro, quello con una nuova donna e l’incoraggiamento degli amici non che forse dello stesso nipote, Severino Ferraris, il figlio della sua affezionata sorella Marietta che sta diventando un affermato artista, gli inietta nuova linfa per continuare a dipingere. Carlo Fornara si spense serenamente il 15 Settembre del 1968 e per volontà sua fu sepolto nel piccolo cimitero di Prestinone, accanto ai genitori e all’amata moglie.
Spostandoci nella pinacoteca di Palazzo San Francesco, troviamo un’altra interessante mostra dedicata al futurismo, dove nell’ingresso brillano alcune opere di Giacomo Balla e Umberto Boccioni, due artisti che prima di diventare dei leader indiscussi del movimento futurista tentarono, assieme a Gino Severini un’esperienza a metà strada fra impressionismo e divisionismo. Tendenze divisioniste si riscontrano in particolare nella prima opera di Umberto Boccioni. Il pittore, figlio di un impiegato di prefettura, nasce a Reggio Calabria nel 1882 e cambia spesso città al seguito dei trasferimenti del padre : dalla natia Calabria si sposta a Forlì, poi a Genova e a Catania, dove completa gli studi. Nel 1899 si reca a Roma e sappiamo che abita presso una zia, foraggiato dal padre che lo manda a imparare l’arte del disegno presso un cartellonista, da cui non impara granchè; fondamentale per l’affinamento della sua arte è l’incontro nel 1900, durante una serata di musica al Pincio, con Severini. Fra i due, desiderosi di sperimentare un’arte nuova, libera dal decadentismo e da un eclettismo magniloquenti e celebrativi, nasce subito una reciproca amicizia. In Italia in quel momento il nuovo è rappresentato da Segantini, Previati, Morbelli, Pellizza da Volpedo e nella capitale i due amici trovano un buon appoggio nella loro voglia di sperimentare : quello di Giacomo Balla, che era stato a Parigi ed era tornato in patria molto penetrato dall’idee dell’impressionismo. Questo è testimoniato dall’opera “Valle Giulia a Roma”, facente parte dell’esposizione a Domodossola. Da come lo ricordava Severini, il Balla dei primi tempi era un pittore profondo e riflessivo, la cui ispirazione si consacrava nella ricerca del vero e da un profondo amore per la natura. Da Giacomo Balla Boccioni assimila l’interesse per i valori luminosi dei colori all’interno di una poetica naturalistica. Attraverso la divisione del colore esso satura le sue composizioni in infinite vibrazioni luminose ma tutto ciò non distoglie l’artista dall’attenzione per il vero, la resa anche minuziosa del reale. Si vedano opere come campagna Romana (1903), fanciullo con il cavallo (1905) , il canal grande a Venezia e il ritratto dell’avvocato C.M.(1907) o un quadro molto poetico come la cucitrice (1908), esposto nel pannello centrale all’ingresso della sala di Palazzo San Francesco e che non veniva più esposto in pubblico dal 1973. Nella scelta iconografica si vede ancora la formazione di Balla, ma si nota anche l’influenza, soprattutto nella luminosità, di Previati che l’artista conosce a Milano (la capitale Lombarda diventerà la residenza stabile dell’artista) proprio all’inizio del 1908 e che trascinerà il Boccioni pre-futurista in una breve adesione al simbolismo. Ma è importante sottolineare come Milano cambi radicalmente il modo di pensare di Umberto Boccioni. Egli stesso dichiara in un suo diario di quel periodo che non ne può più di vecchie mura e vecchi palazzi, di vecchie reminescenze e vecchi motivi. Lui vuole dipingere il nuovo che avanza, il frutto del lavoro industriale. Vuole avere sotto gli occhi la vita del suo tempo. Questa consapevolezza del “nuovo che avanza” esploderà quando il giovane artista incontra il poeta e scrittore Filippo Tommaso Marinetti che il 20 Febbraio 1909 pubblica su Le Figaro, a Parigi, il dirompente pamphlet “fondazione e manifesto del futurismo”. L’incontro dello stesso anno fra Boccioni, Russolo, Carrà e il poeta darà vita al primo movimento artistico d’avanguardia in Europa. Nel 1910 gli artisti stilano il manifesto dei pittori futuristi. Gli artisti dichiarano guerra a tutti gli aspetti dell’arte e della cultura del passato, dell’accademia e del museo. I futuristi intendono non solamente rinnovare il linguaggio dell’arte, ma tutti gli aspetti del lavoro culturale e la società stessa, coi valori del progresso scientifico e tecnologico. I loro soggetti diventano così le luci artificiali, il traffico rutilante delle vie, i treni, gli aerei, i cantieri, le automobili. L’arte deve mutare le sue convenzioni linguistiche, deve essere permeata di un dinamismo “universale” fino a coinvolgere direttamente lo spettatore e porlo “al centro del quadro”. L a luce e il movimento distruggono la materialità dei corpi, trasformandoli in sensazioni, quelle stesse che uno spettatore percepisce ad esempio al passaggio di un treno in corsa, come si vede nel grande quadro di Pippo Rizzo “treno notturno in corsa” del 1926, anch’esso presente alla rassegna Domese. Un quadro che ci fa riflettere sull’importanza che ha avuto, proprio dai primi del novecento, la linea ferroviaria del Sempione nello sviluppo della nostra città.
Alessandro Velli